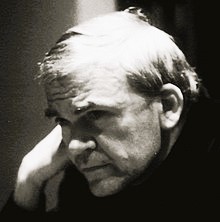A fronte di una vita estetica tormentata lo scrittore vuole togliersi qualche sassolino dalle scarpe cercando di dare il proprio a ciascuno. Innanzitutto a sé stesso. E insieme, che è poi congeniale e identico come processo, ridare il giusto a una tra-dizione penalizzata fortemente dal peso dell’invasione sovietica e dalla considerazione solo formale arrivata dall’Europa. (Europa che Kundera chiama Occidente).
Quanto puntualizzato sarebbe stato diversamente insostenibile in tempi in cui esule cercava una nuova definizione in quel mondo che guardava a Praga come un qualcosa di escatologico. Quel triste destino a cui nessuno poteva far niente. E pare di rileggere l’editoriale di Luigi Pintor su Il Manifesto – “Praga è sola” – che gli costò la ponderata defenestrazione dal Partito comunista italiano. Praga era sicuramente sola ed ha continuato ad esserlo. Inascoltati o almeno poco considerati i suoi numi centrali che Kundera vede in Kafka, Janaceck e Vladimir Holan.
“La cultura di Praga è antica come l’Occidente” (pag. 39) dice esplicitamente Kundera e così tiene a tessere un’originarietà che si sostanzia anche in senso di profondità centrale del pensiero europeo. Sempre l’Occidente però ha avuto il torto di non cogliere l’ondata di innovazione lasciando i cechi in solitudine con la grande mole di contenuti che però non è scomparsa. E’ solo archiviata.
L’innovazione praghese invece consiste nel superamento del messaggio ideologico mascherato all’interno di un romanzo, come di un film o una poesia. Come se fosse il contenuto da inserire in una forma. Nell’arte invece il disvelamento dell’identità nell’unità dei momenti dati per scissi. Quindi la concrezione effettiva di cose, fatti, note e parole superando la ribellione del surrealismo francese. Vivendosi fortemente come espressione del popolo.
Di qui la necessità di un glossario indispensabile per connettere l’ondata innovativa rimasta negli scaffali e segregata da una sorte avversa. Diverse parole chiave. Tra questi ce n’è una che accompagnerà sempre l’autore: ” leggerezza “. Ebbene, non può trovare spiegazione altrimenti perderebbe sé stessa. Ma in polemica con un mondo che l’ha accolto c’è anche la riproposizione del Kitsch. Ha due latitudini. Quella del contenuto popolare fatto passare come messaggio colto, ma anche quello del popolare dato in pasto come unica forma di espressione possibile in una società consumistica. Entrambi lontani dalle latitudini dell’Autore, entrambi pericolose. Ma la prima lo è di più. E gli esempi da fare sono molti.
Milan Kundera, Praga, poesia che scompare, ed. Adelphi 2024, Milano, pagg. 102